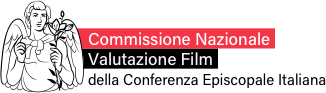Ai Bafta, i riconoscimenti della British Academy of Film and Television Arts, si è aggiudicato i premi più importanti, compresi miglior film, regia e attrice protagonista. Stiamo parlando di “Nomadland”, acclamato film di Chloé Zhao di cui ci siamo occupati sin dall’esordio alla 77a Mostra del Cinema della Biennale di Venezia, dove ha ottenuto il Leone d’oro. Un film che nel corso della stagione ha messo tutti d’accordo, facendo incetta di critiche elogianti e premi, compreso il Golden Globe per la regia, permettendo così alla Zhao di essere la seconda donna a ottenerlo dopo Barbra Streisand con “Yentl” (1984). Ora finalmente siamo a un passo dall’uscita di “Nomadland” in Italia, a fine aprile sulla piattaforma Disney+, e soprattutto dall’attesa notte degli Oscar, domenica 25 aprile, dove l’opera corre per 6 statuette pesanti. Il punto Cnvf-Sir di questa settimana è dedicato dunque al film “Nomadland”, cercando di capire perché (secondo noi) non è solo uno tra i migliori titoli della stagione cinema, ma ci permettiamo di definirlo il più bello dell’anno. Uno sguardo sugli ultimi, raccontati con dignità e dolente poesia.
Il peregrinare di Fern
Nello Stato del Nevada, in una città-azienda andata in rovina, Fern si ritrova da un momento all’altro senza più nulla. È una donna prossima ai sessant’anni che non ha più lavoro, perché la fabbrica è ormai fallita, senza più casa né ragioni per abitarla, dopo la morte del marito. Decide pertanto di caricare i suoi pochi averi su un furgone e di mettersi in viaggio alla ricerca di un domani prossimo, di un modo per sbarcare il lunario giorno dopo giorno. Dove le offrono dei contratti stagionali, Fern parcheggia il suo furgone-casa e diventa stanziale; quando il lavoro finisce, si rimette in marcia. Lungo il suo cammino la donna incontra una vera e propria comunità di nuovi nomadi americani che si sposta lungo le dorsali del Paese in cerca di lavoro, di domani. Così a ogni piazzola Fern ritrova gli stessi volti, le stesse persone, e piano piano si costituisce una vera e propria famiglia della strada, una comunità solidale, gioiosa nonostante tutto e, sì, anche fiduciosa verso il domani…
Quello sguardo tra frontiera e periferia
“Essendo cresciuta in città della Cina e dell’Inghilterra – indica la regista Chloé Zhao – sono sempre stata profondamente attratta dalla strada aperta, un’idea che trovo tipicamente americana: il viaggio senza fine alla ricerca di ciò che si trova oltre l’orizzonte. Ho cercato di catturare quest’idea nel film, pur sapendo che non è possibile riuscire a descrivere veramente la strada americana a un’altra persona. Bisogna scoprirla da soli”. Chloé Zhao è una regista-sceneggiatrice cinese, originaria di Pechino classe 1982, formatasi però in scuole inglesi e statunitensi; curando anche la fotografia e il montaggio, come regista ha firmato tre opere, di cui in particolare si nota la vicinanza tra “The Rider. Il sogno di un cowboy” (2017), che esplora gli spazi rurali dell’America, e l’ultimo “Nomadland”, racconto del territorio a stelle e strisce protagonista insieme a Fern e alla comunità di ultimi che si sposta on the road tra furgoni e camper come un popolo migratore in cerca di presente.
Lo sguardo di Chloé Zhao è assolutamente solido e convincente. La regista quasi quarantenne riesce a cogliere il tessuto che abita le periferie, fotografa gli ultimi nei loro affanni, nelle loro fratture, ma non nella loro disperazione. Il suo non è affatto uno sguardo insistito nel dolore; non ci sono pietismo ricattatorio né forme di carità pelosa. Al contrario, è un guardare negli occhi i poveri di oggi, gli ultimi, quelli che per un twist della sorte o la crisi finanziaria oppure scelte sbagliate si ritrovano ad avere ben poco, ma non per questo sono disposti a lasciarsi inghiottire dallo sconforto o dalla commiserazione. In Fern e nei suoi amici della strada c’è grande fierezza e dignità, c’è la voglia di lavorare sodo e onestamente; c’è il bisogno di scommettere su una ripresa possibile, su una forma di riscatto. La vita non si arresta nella povertà e nella povertà non si è affatto soli; esiste anche un “Noi”, quello che si accende nel segno della solidarietà e della prossimità.
Non è la prima né l’unica ad aver colto tutto questo la regista Chloé Zhao. Il cinema statunitense e europeo sono infatti pieni di cantori degli ultimi, di narratori di esistenze fragili ma non vinte. Possiamo citare i sempreverdi Clint Eastwood, Ken Loach oppure i fratelli Dardenne, possiamo pure richiamare gli sguardi di Pier Paolo Pasolini, di Ermanno Olmi oppure di Vittorio De Sica. È quel cinema dal respiro sociale, civile, che porta a occuparsi di chi è generalmente fuori dall’inquadratura del presente, del popolo degli “scartati” come direbbe papa Francesco. Quello che conquista principalmente dello sguardo di Chloé Zhao in “Nomadland” è la carica di denuncia che sfocia però nella poesia e nella dolcezza. Non usa il graffio, la macchina da presa come incalzante occhio di inchiesta, bensì come finestra aperta su un’umanità piegata ma non sola e soprattutto non arresa. Una comunità resiliente, che regala emozioni luminose e vibranti.
La strada, nella sua struggente bellezza
Lungo la strada il personaggio di Fern, interpretato da una Frances McDormand di rara e inarrivabile bravura – le devono riconoscere l’Oscar come miglior attrice, non ci sono alternative! E sarebbe anche il terzo dopo “Fargo” (1997) e “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” (2018) –, non perde se stessa, anzi si ritrova. All’inizio del racconto Fern è sola, segnata dalla vita, con i lividi ancora violacei nell’animo. Troppi i “lutti” che ha dovuto fronteggiare: marito, casa, lavoro. La strada non si rivela un sentiero di deragliamento ulteriore, ma di rigenerazione. Mettendosi in cammino, non rimanendo ferma, Fern vive, torna a nuova vita.
In primo luogo la donna si accorge di non essere affatto sola, ma che come lei ci sono tante donne e uomini chiamati a ripensarsi, a ritrovarsi. Fern fa pacchetti in un centro di produzione di Amazon, pulisce bagni in un camping, come pure si occupa di una tavola calda in tipico diner, ecc. Ogni lavoro è un’occasione per riaffermare la sua dignità e per incontrare compagni solidali nella precarietà. E la sera, davanti al fuoco acceso nella piazzola tra furgoni e camper, ci si mette a cantare e si accarezzano i ricordi, quelli che un tempo facevano male, che toglievano il sonno mentre ora sono essenziali al cuore, che fanno provare emozioni intense e riconcilianti. Da questo viaggio on the road, profondamente esistenziale, Fern ne esce come una persona migliore: si scopre resiliente, capace, viva. Non è ancora pronta per innamorarsi di nuovo, non sa se lo sarà in futuro, ma è pronta per tornare a sperare che la vita possa riprendere il suo giro e che magari le possa schiudere ancora qualcosa.
Per questo e per gli elementi che abbiamo citato riteniamo “Nomadland” non solo meritevole dei vari Oscar per cui corre, ma soprattutto del riconoscimento più importante, l’abbraccio del pubblico. “Nomadland” è un film che fa bene all’animo, perché allarga lo sguardo sulle zone della vita generalmente in ombra, cui spesso si fa fatica a volgere l’attenzione, lasciando in dono il valore della speranza e della resilienza, oltre che il bisogno di tornare a scommettere convintamente sulla solidarietà. A ben vedere, la pandemia da Covid-19 ci ha ferito, isolato, rinchiuso, spingendoci ad avvolgerci smarriti intorno all’“Io” personale-familiare; “Nomadland”, come il grande cinema sa fare, ci ricorda che esiste un “Noi” fuori, in mezzo alla strada, un mondo fatto di incontri, di prossimità e anche di sorrisi densi di fiducia. E allora come dice Fern nel film, è ora di tornare a ritrovarci “lungo la strada”.
Film potente, bellissimo, segnato da diffusa poesia, “Nomadland” dal punto di vista pastorale è da valutare come raccomandabile, problematico e adatto per dibattiti. Il film ha ricevuto alla Mostra del Cinema della Biennale di Venezia la menzione speciale del premio cattolico internazionale Signis.
Articolo disponibile anche sul portale dell’Agenzia SIR